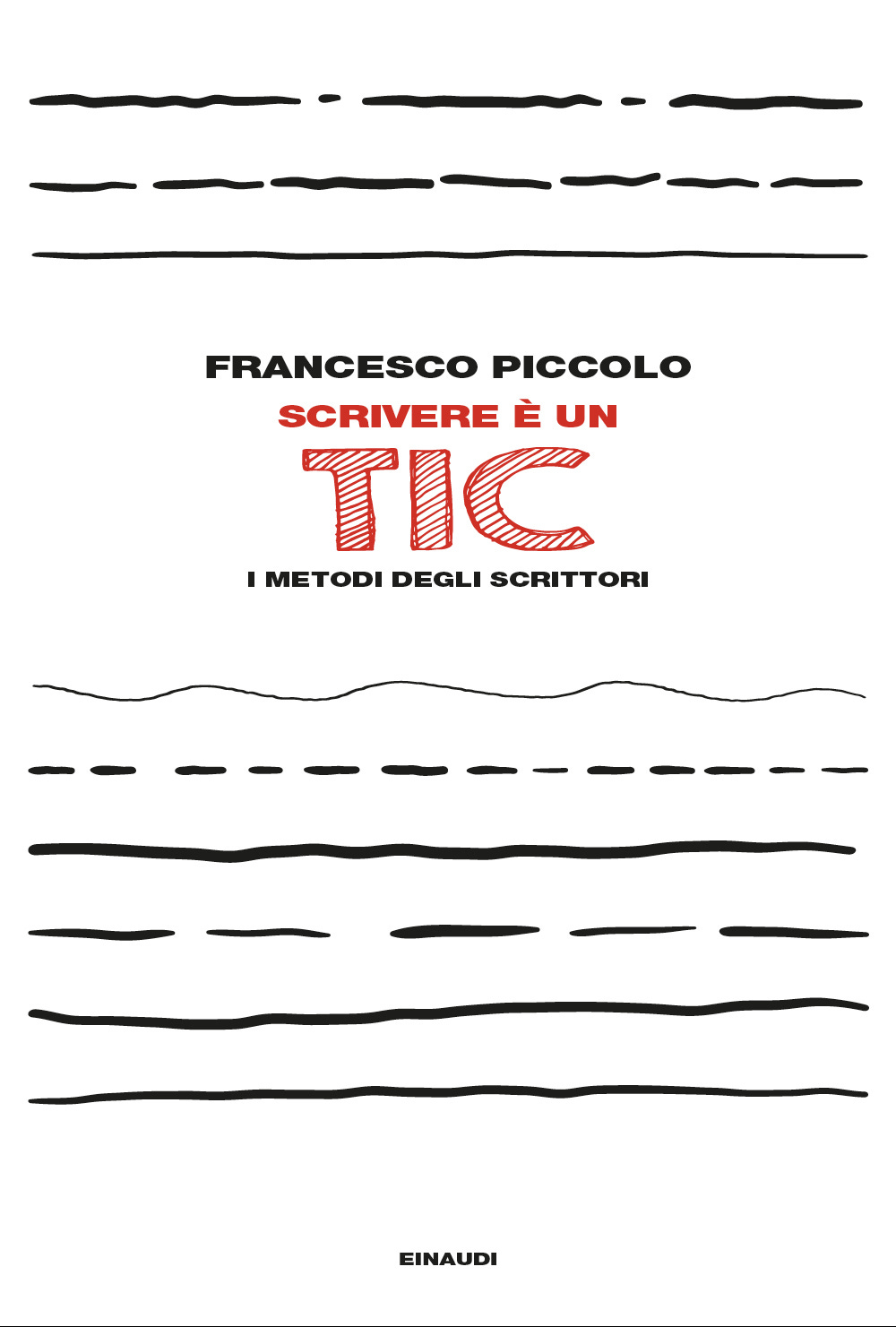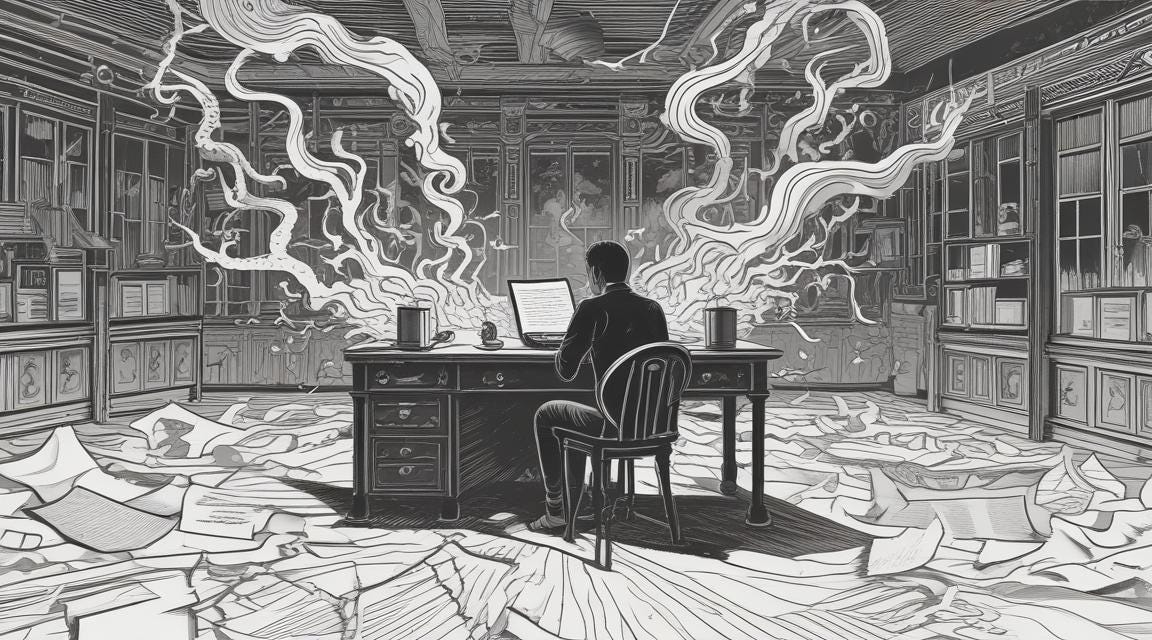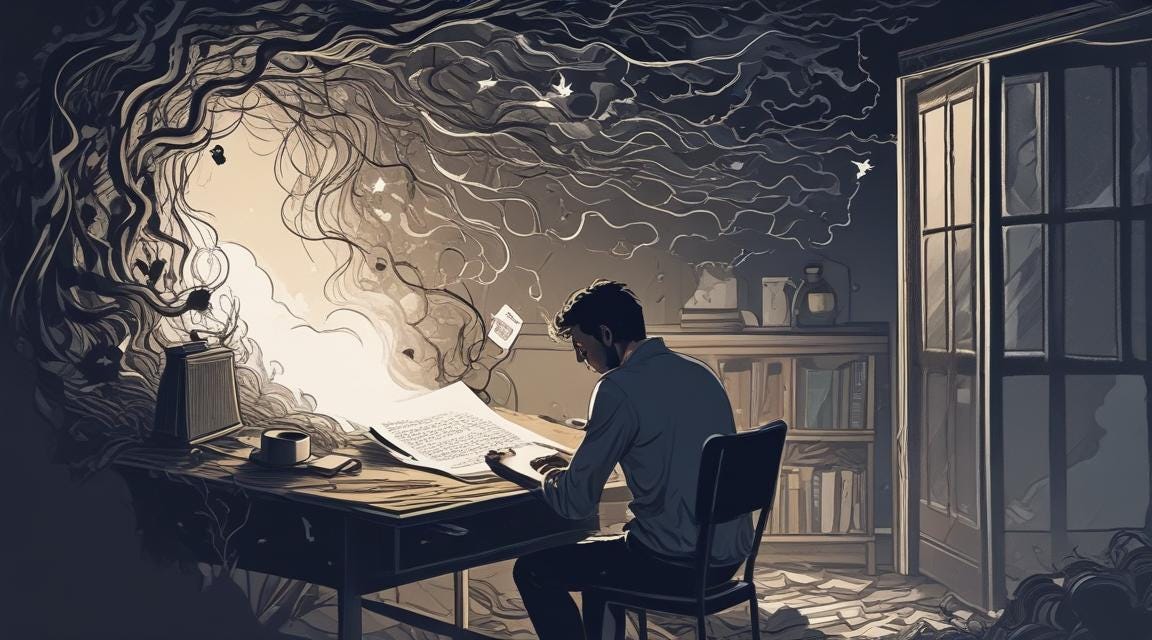Come si diventa scrittori
Un lavoro creativo è pur sempre un lavoro, come spiega un libro appena ristampato sui metodi usati dagli scrittori per sconfiggere le pagine bianche
Cari amici dell’orso Bruno,
Da quando mi sono licenziato e ho iniziato la carriera da freelance la cosa più difficile a cui rispondere è ovviamente la fatidica domanda: «Che lavoro fai?». In estrema sintesi, scrivo per vivere – ma poi il modo in cui questo si realizza è molto più difficile da spiegare. È un po’ come quell’aneddoto raccontato dallo scrittore cileno Luis Sepúlveda: «Mi ricordo sempre di un ufficiale di dogana a Quito: ogni volta che dovevo mendicare un visto mi chiedeva la professione. Quando gli rispondevo: “Scrittore”, ripeteva: “Le ho chiesto la professione”».
Questa citazione è tratta da Scrivere è un tic, un libricino di Francesco Piccolo, uscito da poco in una nuova edizione per Einaudi. È una riflessione divertente e piena di aneddoti su come gli scrittori abbiano trasformato un talento in un lavoro, o almeno ci abbiano provato. È una riflessione sul fatto che la scrittura richieda un certo metodo e una certa professionalità, con una fatica che ricorda quella che serve per molti altri mestieri.
Il problema è che il riconoscimento sociale è molto più complesso: la scrittura è vista comunemente come un passatempo.
«Chiunque può prendere un foglio e una penna, o mettersi davanti al computer, e scrivere un racconto; e considerarsi scrittore», spiega Piccolo.
«Non solo, ma paradossalmente si può considerare scrittore anche chi non scrive, perché se tutto è frutto di una combinazione tra ispirazione, luna piena e sofferenza d’amore, si può sempre rimandare una poesia o un romanzo, si può pensare di essere uno scrittore senza avere ancora trovato le condizioni favorevoli per scrivere».
«E succederà un giorno che la nostra donna (o il nostro uomo) ci lascerà; torneremo a casa di notte, ci sarà la luna piena e non potremo dormire, il cuore sarà gonfio di lacrime e prenderemo un foglio e cominceremo a scrivere: “Mia amata…”. Ecco, questo non significa essere scrittori».
Fogli bianchi
Nel caso dei giornalisti ci sono ovviamente delle differenze: la professione è un po’ più riconosciuta nel suo ruolo sociale, talvolta anche con qualche pregiudizio negativo (non sempre infondato). Però poi – quando si entra più nel concreto – la confusione aumenta: che cosa accomuna l’inviato di guerra che schiva i proiettili e chi come me sta per gran parte del tempo seduto davanti a un computer, cercando di spiegare concetti complicati in termini semplici, col solo rischio che intanto si alzino i livelli di colesterolo?
La verità è che c’è solo una cosa che rende tutti uguali quelli che si guadagnano da vivere scrivendo, in qualsiasi modo lo facciano, dal romanziere al pubblicitario: il fatto che ci sia una pagina bianca da riempire.
A volte sembra che abbia una sua personalità e che si scriva da sola, come se fosse una magia. Ma altre volte – la maggior parte delle volte, a dire il vero – bisogna faticare su ogni parola, sudare come si fa per qualsiasi lavoro, anche il più bello al mondo. Scrivere, riscrivere, ed essere spesso insoddisfatti.
Il metodo
Ed è qui che entra in gioco quello che differenzia l’amatore e il professionista, che è così difficile da raccontare e che viene spesso sottovalutato anche da chi questo lavoro lo fa. Bisogna costruire un metodo per rendere la scrittura davvero una cosa seria.
Purtroppo non esistono ricette: ognuno deve trovare la sua, frutto di anni e anni di tentativi. Per ogni professione esiste un periodo più o meno lungo di apprendistato ed è esattamente lo stesso anche per le professioni creative. Si supera la fatidica linea rossa quando si trova il proprio modo di lavorare; talvolta nasce appunto da un tic – da un rituale al limite della nevrosi, che per un esterno può sembrare persino folle (e talvolta lo è davvero).
Non tutti possono diventare Flaubert, ma anche Flaubert per diventare uno scrittore ha dovuto costruire un suo metodo. Ovviamente non è sufficiente per riuscire a scrivere in maniera efficace, ma soltanto così si riesce a durare nel tempo, anche quando la passione si esaurisce, magari cercando persino di fatturarci sopra qualcosa.
Il coraggio di oziare
C’è poi un altro aspetto poco considerato da chi non conosce questo lavoro: il fatto che il momento in cui si scrive è spesso solo l’ultimo atto di un processo creativo.
Lo spiega ancora Francesco Piccolo:
«Il mestiere di scrittore è un mestiere dove si perde anche tempo. Anzi, perdere tempo è cosa necessaria per chi scrive. Questo concetto, che sembra antitetico alla fatica creativa, è invece il suo naturale accompagnamento: uno scrittore deve saper perdere tempo, perché è necessario per la ricarica di energia, è necessario per pensare, o per non pensare più a un passaggio ossessivo».
«Scrivere è faticoso perché bisogna pensare molto, e se uno è sempre indaffarato non può farlo. Bisogna avere il coraggio di oziare. Di solito siamo soddisfatti quando abbiamo la giornata impegnata dalla mattina alla sera. Lo scrittore dovrebbe fare il contrario, cioè svuotare la vita da impegni e lasciare spazio alternativamente alla scrittura e all’ozio».
Ovviamente questa può sembrare una provocazione, o quanto meno un modo per auto assolversi quando si è meno produttivi. In realtà nasconde un verità di fondo: in quei posti di lavoro dove le persone sono spremute fino all’ultimo briciolo della loro vitalità, in cui si colpevolizzano lo smart working o le ferie, in cui si costruisce un ufficio di impiegati in burnout, difficilmente si farà della buona letteratura. O del buon giornalismo.
Il risultato è ovviamente che ci sono anche profonde disuguaglianze, con certi lavori creativi che sono riservati a determinati ceti sociali, che per altro racconteranno solo le storie che andranno bene a loro.
L’orgia di parole
Ad essere davvero democratico è invece quello strano fenomeno che viene chiamato “blocco dello scrittore”, in una definizione che mi ha sempre fatto pensare al “gomito del tennista”. Qualche giorno fa ne ha scritto anche Marco Archetti sul Foglio.
A partire da una lettera di Franz Kafka, in cui lo scrittore si rifiuta di ideare un racconto per la rivista di un amico e lo fa con una motivazione sconcertante, perché scritta da uno dei più importanti autori del Novecento: «La verità è che sono tre anni che non scrivo». In un’altra lettera, indirizzata alla scrittrice boema Milena Jenesenská, lo dice con altre parole: «Cara Milena, oggi voglio scrivere di altre cose, ma le cose non vogliono».
Scrivere significa fare a patti con i limiti della creatività umana, con l’imperfezione che siamo tutti, con gli ostacoli che l’umanità crea perché questa è la sua natura. «Chiunque scrive», spiega Archetti, «sa che sarebbe meglio non scrivere». Perché a un certo punto ci si rende conto che l’insoddisfazione deriva dall’impossibilità di tradurre in parole certe cose che si provano dentro, o si osservano fuori, e che semplicemente non possono essere espresse.
Eppure – osserva ancora Archetti – siamo in un tempo in cui scrivono tutti e ovunque, dai messaggi su WhatsApp ai libri di ex generali dell’esercito. E se il blocco dello scrittore fosse proprio una reazione a quest’orgia di parole?
Per questo episodio è tutto,
Daniele